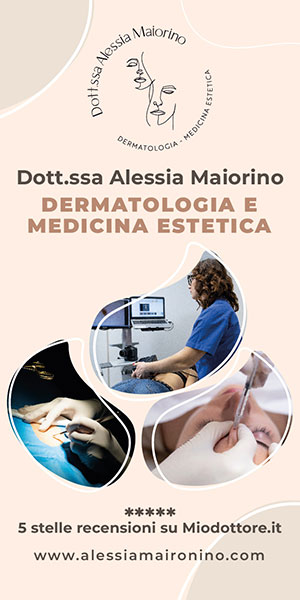Martedì 20 febbraio ore 20.30, in Sala Assoli, debutta Il fiore che ti mando l’ho baciato, dal carteggio 1913/1915 tra Stamura Segarioli e Francesco Fusco, scrittura scenica e drammaturgica di Elvira Buonocore, Anna Rita Vitolo e Antonio Grimaldi. Una storia familiare che diventa, grazie al teatro, memoria collettiva: nato in occasione delle Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale, lo spettacolo porta in scena la corrispondenza tra un medico tenente dell’esercito e l’amata che non sposò mai. È la guerra che scrive alla pace nel tormento di un amore a distanza. Il racconto sopravvive grazie alla volontà della nipote Rosa Fusco e su iniziativa del Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo, presieduto da Antonia Lezza, presso la cui biblioteca è custodito il materiale inedito degli eredi Fusco. Unica interprete in scena, Anna Rita Vitolo (conosciuta al grande pubblico per l’interpretazione della madre di Lenù nella serie televisiva L’amica geniale), diretta da Antonio Grimaldi. Lo spettacolo è prodotto dal Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo e Teatro Grimaldello. Replica mercoledì 21 febbraio ore 20.30. Costo del biglietto per gli spettacoli: intero 18 euro; ridotto 14 euro Per info e prenotazioni:345 467 9142 – assoli@casadelcontemporaneo.it
La figura epica, lirica, della donna che attende, con straziato pragmatismo, sulla soglia, facendo mostra di una inguaribile fedeltà, di quel granitico attaccamento all’uomo è un topos letterario a cui siamo avvezzi. Ma l’attesa, in questo caso, non è lo sfondo delle grandi imprese di lui, che altrove esprime sogni e ambizioni. L’attesa è il sentimento stesso, è la nervatura, lo scheletro dell’amore tra Stamura e Francesco. È una sottilissima speranza che si allunga, stringata, come un filo nel tempo. È qualcosa che forse oggi siamo più disposti a comprendere. Non è per decenza che Stamura aspetta un uomo, non è per buona misura, per ossequio, per prudenza. L’amore qui assume significato nella dimensione vocale, nel chiamare l’altro, nel pronunciare il suo nome o un vezzo al posto di quello, come: “caro, carissimo, mio amore”. In quest’ottica, la pazienza di Stamura, la sua invidiabile continenza, assume dimensioni più ampie, titaniche, e per nulla remissive: aspettare non è un atto di femminile sottomissione, ma è amore. Sentimento che vive di fiato, appunto, di voce nella reciprocità. Del resto anche Francesco attende.
«È esattamente dalla voce che ci serve ripartire, cercando il filo del garbuglio emotivo che rappresenta ogni volta una scrittura, specialmente quella teatrale – spiega Elvira Buonocore. Una facoltà, la voce, che si esprime con il fiato, ossia con le profondità umide: è la nostra parola che si esprime, una emissione che precipitando va a segno. Ma questo percorso implica sempre qualcun’altro. La voce, e con lei tutto il nostro significato amoroso, intrepido, ribelle, viaggia come un singolo pezzo sventurato di desiderio che cerca l’altro senza sosta; è proprio l’altro che le dà significato, che restituisce a quella voce una ragione per esistere. È vocale, dunque, il filo che ha tenuto insieme, fin dal principio, il lavoro di scrittura drammaturgica: un’architettura testuale assai simile a una partitura per la cura dei tempi, dei boati che si alternano ai silenzi, per le pause che vibrano di paura. Le parole di Stamura, intrecciate a quelle eleganti di Francesco, sembrano la parte solista di una sonata assai complessa, un concerto per orchestra in cui la sua voce di donna canta l’attesa. E alla lirica penso – quando immagino la furia di parole che Francesco, medico tenente dell’esercito di Carano di Sessa Aurunca, lancia lontano, fuori dalla sua trincea, come una pioggia di dardi infuocati: “Sento ancora la stretta convulsa delle tue dita come quella delle tue braccia, quando gemi e sorridi con tutte le grandi e vive emozioni che mi restano nell’anima. Il cuore mi batte forte forte, mi tremano le gambe e come un ebete, a te attaccato, resto privo di volontà e di energia”».